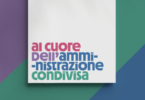Il convegno, cui hanno partecipato l’On. Michela di Biase, il Senatore Andrea Marcucci, i Dottori Christian Caliandro e Massimo Fantini, si pone alla fine di un percorso condiviso ed ha presentato il Manifesto che definisce principi e requisiti di un soggetto giuridico nuovo, slegato da forme che non rispondono più a necessità e bisogni attuali.
” Ci siamo chiesti quale fosse il compito dell’amministrazione – introduce Michela Di Biase – ed abbiamo capito che era necessario un dialogo sul fatto se esistesse, e quale fosse, la forma giuridica di questo tipo di impresa. ”
Il Manifesto dell’impresa culturale
#FondatiSullaCultura è un movimento che coinvolge gli operatori privati della cultura: persone, cioè, che vivono e guadagnano realizzando progetti culturali in Italia attraverso diverse forme giuridiche – associazione culturale, fondazione, società commerciali (società lucrative e cooperative) – ed in diversi settori. Essi sono accomunati dalla necessità di applicare un modello giuridico che sia adatto alle attività condotte, senza dover più far riferimento a forme giuridiche ” pensate a partire da un mondo che non considerava le attività culturali come un possibile settore di attività di impresa ” .
Si richiede per questo una nuova forma giuridica che consenta di operare nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità , ma che al contempo permetta di riconoscere e misurare il suo valore, ” inteso come strettamente economico ma anche sociale e culturale ” .
L’impresa culturale, tra i suoi obblighi, deve avere un impatto sulla comunità e sul territorio, ovvero la capacità di influire sui comportamenti sociali e di coinvolgere e aggregare attraverso i suoi prodotti culturali, ed è necessario che abbia tra i suoi obiettivi la valorizzazione del patrimonio nazionale.
Un vecchio problema
E’ stata poi data lettura della lettera di Flavia Nardelli, vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati che, seppur non presente, ha voluto esprimere apprezzamento per questa iniziativa: ” mi sono più volte scontrata con il problema dell’assenza di un’adeguata fattispecie giuridica capace di inquadrare la complessità del mondo impegnato sui diversi aspetti della managerialità culturale. Stefano Zamagni tentò di risolvere il problema quando si trattò di costituire realtà di questo tipo, nella fattispecie delle onlus. Fu allora che il problema si evidenziò immediatamente. Fu necessario in quel caso fare riferimenti ulteriori per chiarirne la natura, quali l’inserimento nella tabella del Mibac disposta dalla legge 534/1996, riservata agli istituti di alto valore culturale, oppure l’appartenenza alla tabella del Miur introdotta dal Decreto Ministeriale del 2001. In questo modo però il problema non veniva risolto: rimaneva l’incertezza di una collocazione giuridica che poteva essere rimessa in discussione dall’applicazione dell’una o dell’altra tabella, o dalla ridefinizione di nuovi requisiti che impedissero a questi enti di farvi parte. Ordinandone la tutela, il riordino del nostro patrimonio culturale deve essere collegato con la sua valorizzazione e promozione. Oggi questa è una grande sfida che vede impegnate le realtà culturali più attente. In epoca di Art Bonus e di necessità di far convivere in maniera proficua il finanziamento pubblico per la cultura e con il sostegno dato dai privati, dobbiamo fornire gli strumenti più idonei al buon funzionamento delle imprese culturali. Il numero degli addetti ai lavori è tale da giustificare la richiesta di intervento del legislatore. Per questo il risultato di questi lavori sarà oggetto di un’analisi attenta da parte della Commissione Cultura della Camera dei Deputati per valutarne le potenzialità ” .
LEGGI ANCHE:
- Legge 29 luglio 2014, n. 106
- L’Italia agli italiani: istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale
- Il Manifesto delle Seconde Generazioni
- L’ impresa sociale in Italia
ALLEGATI (1):